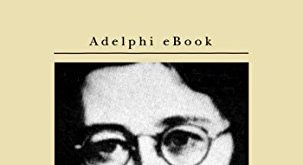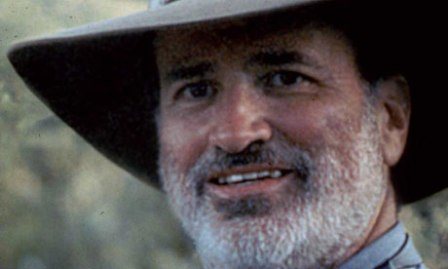Scritto da Simone Weil all’inizio del 1943, poco prima della morte, il breve saggio La persona e il sacro è una sintesi della sua antropologia. Non possiamo dire che qualche essere umano non ci interessa senza ferirlo e senza commettere una grave ingiustizia, però possiamo legittimamente dire che la sua persona non ci interessa. Ma anche in riferimento a se stessi la differenza tra se stessi e la propria persona è essenziale. Infatti, ammonisce la Weil, posso dire «La mia persona non conta” senza degradarmi, ma non posso autoflagellarmi e screditarmi dicendo “Io non conto”» (p. 11). Una determinata persona o la persona umana non hanno nulla di sacro. Sacro è invece un certo uomo in carne ed ossa. Inutile quindi volersi appellare alla persona, che Weil considera una nozione sbagliata. «Se quel che vi è di sacro in lui per me fosse la persona umana, potrei cavargli gli occhi facilmente. Una volta cieco, sarà una persona umana esattamente come prima» (p. 12). Neppure se aggiungiamo i diritti della persona umana andremo lontano. Si tratta di nozioni vuote, ancorate a nulla e quindi suscettibili di essere utilizzate per giustificare qualsiasi tirannia. Di più: se un uomo fosse sacro nella sua interezza, non lo sarebbe per le sue braccia lunghe, per i suoi pensieri mediocri, per la sua occupazione − per nessuno degli aspetti particolari che lo caratterizzano.
Read More »Kafka o l’assenza dell’attesa: il radicale disincanto dello scrittore cecoslovacco per mettersi al riparo dalla tentazione di ogni illusione
Il radicale disincanto che pervase il pensiero e il sentimento della vita di Kafka non risparmia nemmeno la letteratura, che tuttavia fu alla base della sua vita. Egli scelse di scrivere non come tentativo di sfuggire all’infelicità o all’inadeguatezza, ma per mettersi al riparo dalla tentazione di ogni illusione. Questa negazione, all’origine, dell’attesa è l’angolazione assoluta da cui Bataille sembra guardare Kafka. Dopo aver sottolineato, non senza ironia, che la proposta-interrogativo dei comunisti di bruciare Kafka era stata preceduta dalla volontà o almeno dal desiderio dell’autore, Bataille afferma: «Capì che la letteratura gli rifiutava la soddisfazione attesa, e questo egli voleva: ma non cessò di scrivere. Sarebbe anzi impossibile dire che la letteratura lo deluse. Essa non lo deluse, ad ogni modo, in paragone ad altre finalità possibili» (LM, IX, 272; 138). A questo punto Bataille si inoltra nell’atmosfera e nel linguaggio kafkiani per ammettere che forse la letteratura fu per Kafka ciò che ai suoi occhi era stata la Terra Promessa per Mosè. Bataille ci indica, attraverso una pagina dei Diari, che idea avesse Kafka della Terra Promessa a Mosè. Scriveva Kafka: «Il fatto che egli giunga a vedere la Terra Promessa soltanto alla vigilia della morte non è credibile. Questa suprema prospettiva ha un unico senso, quello di rappresentare fino a che punto la vita umana sia un istante imperfetto: imperfetto perché questa specie di vita (l’attesa della Terra Promessa) potrebbe durare indefinitamente senza che ne risultasse mai qualcosa di diverso da un istante. Mosè non raggiunse Canaan non perché la sua vita fu troppo breve, ma perché era la vita di un uomo» (LM, IX, 272;138).
Read More »‘To the Wonder’ e ‘The tree of life’ di Malick, due film complementari sull’individuo costantemente contrapposto alla storia
Indubbiamente con To The Wonder, la matrice del cinema di Terrence Malick è definitivamente venuta allo scoperto, confermando quanto già si poteva intuire nel precedente The Tree of Life. Con quest’ultimo, contestatissima Palma d’oro a Cannes 64, il regista texano aveva mostrato inequivocabili segnali di una profonda crisi mistica, aprendo ad un nuovo corso del suo esercizio cinematografico. “Neonata. Apro gli occhi. Fondo. Nella notte eterna. Una scintilla”: questo l’incipit, le prime parole off pronunciate dalla voce interiore di Marina in To the Wonder (Olga Kurylenko). Parole che fanno da eco a quelle dolenti di Jack (Sean Penn) in The Tree of Life (“Come ti ho perduto? Mi sono allontanato, ti ho dimenticato”), riattivandone in un battito di ciglia il substrato gnostico. Secondo la gnosi, dottrina antichissima dalle ramificazioni straordinariamente estese, l’essere umano è caduto nel mondo, gettato nella prigione terrestre, addormentato, ignaro della propria reclusione nella vita mortale e dimentico della scintilla divina che, sopita, dimora in lui. Venire al mondo significa dunque precipitare nell’oscurità della materia, nell’inconsapevolezza della propria origine, nella perdizione. La creazione non è opera della bontà divina, ma il prodotto di una divinità malvagia (Demiurgo): è tenebra, divisione, incompletezza, corruzione del Pleroma (la luminosa pienezza originaria). Creazione sta per catastrofe, in una parola. Si tratta di un dramma immane e incontrollabile di fronte al quale non si può che piangere (è forse un caso che in The Tree of Life la cosmogenesi sia accompagnata dalla Lacrimosa di Zbigniew Presner?).
Read More »‘L’Iliade o il poema della forza’, l’inesorabile peso con cui la forza schiaccia anche i vincitori secondo Simone Weil
L’Iliade o il poema della forza è un saggio scritto da Simone Weil fra il 1936 e il 1939: l’attualità e la freschezza delle riflessioni della filosofa francese – che rileggendo l’Iliade mette a nudo l’inesorabile peso con cui la forza schiaccia sia vinti che vincitori – costituiscono un sano esercizio intellettuale per interpretare quella che sembrerebbe essere una categoria meta-storica che permea il divenire dall’antica Grecia alla contemporaneità. La forza, e la necessaria violenza attuale o potenziale che la accompagna, lasciano a chi ne è momentaneamente in possesso infinita libertà di agire e di muoversi in uno spazio senza costrizioni. Essa elimina necessariamente quell’intervallo di riflessione che interviene fra il pensiero di un’azione e la sua realizzazione: che motivo avrebbe Agamennone di ponderare le conseguenze del sottrarre Briseide ad Achille, sapendo che questi non potrà nulla a riguardo?
Read More »‘L’azzurro del cielo’, il secondo romanzo erotico del filosofo George Bataille: la ricerca della purezza nel torbido
George Bataille (1897-1962) è stato un intellettuale complesso e discusso. Scrittore, filosofo, sociologo, etnografo, disse di se stesso: “io non sono un filosofo, ma un santo, forse un pazzo”. Forse è proprio quest’ottica di sacrificio (santità) e di gioia mistica (pazzia) la chiave di lettura di Blue du Ciel, L'azzurro del cielo, secondo romanzo erotico – il primo fu Histoire de l’oeil (1928) – in cui confluisce l’episodio “Dirty” scritto già nel 1927. Due le principali influenze letterarie: Sade e le Memorie del sottosuolo di Dostoevskij, tuttavia quest’opera non può essere separata dal resto della produzione batailliana. Vi si sentono un non completo abbandono delle idee rivoluzionario-surrealiste nonché un’anticipazione dell’esistenzialismo francese, anche se in chiave “impolitica”. Con Paolo Tamassia: “il rifiuto della dialettica non significa certo per Bataille l’accettazione rassegnata dello status quo, quanto piuttosto l’avvio della ricerca di uno strumento adatto a sovvertire radicalmente lo stato delle cose, che non sia però suscettibile d’essere volto in positivo. Insomma: un “dispendio senza impiego” difficilmente digeribile per gli intellettuali dominanti dell’epoca.
Read More »Simone Weil, tra i più grandi filosofi del Novecento, fuori da un qualsivoglia sistema entro cui ripararsi, rigorosa cercatrice di Verità anche a scapito della Vita
Filosofa, sindacalista, insegnante, operaia, rivoluzionaria, soldato, idealista, anarchica, mistica, ebrea, cattolica, Simone Weil era tutto questo e molto altro ancora, e la sua vita, più delle sue opere, testimonia di una personalità sempre coerente, esplosiva, anticonformista. Nasce a Parigi nel febbraio del 1909 da una ricca famiglia ebrea. Un’anima sensibile quella della Weil, che a soli quattordici anni affronta una prima crisi esistenziale accompagnata da forti emicranie. Superata la crisi ai tempi del liceo, diviene allieva di La Senne e Alain – quest’ultimo rimase un esempio per l’attivismo politico – ottiene la laurea in filosofia nel 1931 all’Ecole Normale Superieure. E’ a questo punto che comincia la carriera vera e propria della Weil divenuta, subito dopo la “licence”, insegnante di filosofia nelle piccole città di provincia di quella Francia ancora scossa dalla guerra. Ad una vita di soli studi ed insegnamento, Simone Weil accosta con vocazione sempre più intensa la sua passione per il mondo sindacalista, rivoluzionario e anarchico, con una dose di ispirazione marxista.
Read More »‘Raffaello e l’eco del mito’ in mostra dal 27 gennaio 2018 al 06 maggio 2018 a Bergamo
Raffaello è il protagonista della stagione espositiva 2018 di Bergamo con la grande mostra Raffaello e l’eco del mito che anticipa le celebrazioni dell’anniversario, nel 2020, dei 500 anni dalla morte del maestro urbinate, attraverso un inedito percorso di oltre 60 opere, provenienti da importanti musei nazionali e internazionali e da collezioni private. Il progetto scientifico della mostra ha preso avvio dal San Sebastiano di Raffaello, il capolavoro giovanile parte delle raccolte della Carrara, non solo protagonista di una sezione dedicata ma centro dell’indagine espositiva che si sviluppa attraverso vari capitoli: le opere dei “maestri” come Giovanni Santi, Perugino, Pintoricchio e Luca Signorelli, raccontano la formazione; un significativo corpus di opere di Raffaello ne celebra l’attività dal 1500 al 1505; infine, il racconto del mito raffaellesco si sviluppa in due sezioni, la prima ottocentesca e la seconda dedicata ad artisti contemporanei.
Read More »Pasolini e Thibon, l’intellettuale scomodo e il ‘filosofo contadino’ uniti nel parteggiare per il reale
Gustave Thibon e Pier Paolo Pasolini, personalità estremamente differenti ma simili; vite e sensazioni diverse, dai gusti netti, radicali, ma intimamente anelanti il sacro. Da più di una decina d’anni, probabilmente una ventina, descrivendo l’epoca nella quale viviamo – o per meglio dire, sopravviviamo – accademici, sociologi e politici non fanno altro che ripetere che tutti gli schematismi nei quali si era immersi sino alla caduta del muro di Berlino, non hanno più alcuna valenza, se non quella assegnata loro dalla storia. Ecco allora che politicanti affaccendati – un po’ per esprit democristiano mai sopito, un po’ per mostrare di saperne qualcosa – si sforzano di ripetere con meticolosi gargarismi che destra e sinistra non esistono più. Non ha senso dividersi, non vi è ragione di identificarsi in categorie morte, ma di puntare alla prassi, al fattuale, al concreto.
Read More » '900 Letterario | Letteratura del '900, critica, eventi letterari, cinema, politica, attualità Divulgazione culturale e informazione libera
'900 Letterario | Letteratura del '900, critica, eventi letterari, cinema, politica, attualità Divulgazione culturale e informazione libera