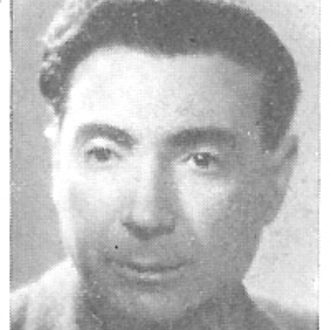All’albergo del Sole è un volume del 1932 dello scrittore, commediografo e critico teatrale siciliano Giuseppe Lanza che segue le due commedie, del medesimo autore, Esilio e Ritorni. L’accento di Lanza cade, con uno stile molto personale, su un complesso di sentimenti della ricerca della felicità, sentimenti che caratterizzano i personaggi delle sue opere e che ci parlano del mondo morale dell’autore siciliano; personaggi incapaci di raggiungere una pienezza di vita che assumono contorni più delineati e articolati in All’albergo del Sole, il cui protagonista è un tormentato, un fratello spirituale di personaggi delle commedie di Lanza.
All’albergo del Sole: trama dell’opera
Ma se la sua parentela con loro è molto evidente, il suo stato d’animo, la sostanza intima dei suoi modi ha una complessità maggiori. Qui Lanza ha scavato più a fondo nei suoi personaggi: atteggiamenti e movimenti psicologici che nei personaggi di Esilio e Ritorni si pronunciavano con qualche impaccio, dando all’atmosfera delle commedie qualcosa di sfuggente, in Luigi, protagonista de All’albergo del Sole, li vediamo giocare in modo più articolato. La fisionomia etica di Luigi è dunque messa a fuoco con una sicurezza che nelle commedie si avvertiva solo a tratti; Luigi è un giovane con delle aspirazioni artistiche, ma nello stesso tempo possiede una coscienza molto acuta e sa che tali aspirazioni non possono essere realizzate senza un forte impegno della volontà e soprattutto senza essersi prima conquistato una maturità spirituale che nella sua mente deve collimare con lo stato creativo cui tende la sua vita intima come alla piena realizzazione di se stesso. Luigi ha sempre rimandato: il bisogno di una sicurezza pratica e le distrazioni amorose mentre lo tenevano impegnato, gli davano più acuto il tormento dell’attesa insieme al timore di non poter raggiungere il proprio obiettivo, il proprio sogno.
Lanza coglie il suo personaggio nel massimo momento della sua crisi, quando ha fatalmente deciso di staccarsi da un suo socio con il quale aveva un’azienda in comune, e quando sente il vuoto di una relazione d’amore che gli aveva bruciato i sensi Luigi a scatti decisivi alterna timori, ansie e paure, stanchezze della volontà. La trama delle sue azioni è costituita da questo alternarsi di elementi psicologici che non riesce a dominare e proprio questa mancanza di dominio è il segno del suo destino, della sua personalità. In un albergo sul lago di Garda dove ha portato l’ultima amante della quale è stufo ma da cui si sente ancora attratto fisicamente, Luigi incontra una ragazza malata e se ne innamora. Sembra essere una febbre improvvisa con una punta di morbosità , l’uomo sente che quella è la donna di cui ha bisogno, in altri momenti l’oscura voce dell’istinto sessuale gli dice che Jole non è la donna per lui. A questa alternativa se ne aggiunge un’altra: Jole è ricca e rappresenta un’ottima occasione che contribuisce al suo destino di artista. Dopo essersi fidanzato con Jole, Luigi le espone il suo stato d’animo, confessione che sarà fatale per la ragazza.
Narrazione e stile
La narrazione di All’albergo del Sole è distesa e serrata a un tempo, ricca di complesse interferenze e Lanza dimostra di avere totale padronanza e coscienza sul suo soggetto, fino a risolvere, talvolta in riassunti psicologici, momenti che andavano distesi in tessuto narrativo. Ma a parte queste piccolissime pecche, Lanza con quest’opera, ha dato la prova migliore delle sue qualità narrative su una materia non di facile resa, bloccando la tensione tormentosa del suo protagonista: un uomo in cui volontà e azione non coincidono, che si propone una cosa e ne fa un’altra. L’altra parte del volume è costituita da tre brevi racconti, ma senza dubbio il racconto di maggiore impegno di Lanza è quello che ha dato il titolo all’intera opera e in esso non è difficile scorgere un narratore che ha avuto il merito di non ridurre i complessi moti dell’animo in un ambito esclusivamente sensuale e sessuale, restringendo a un punto solo la vasta gamma dei sentimenti.
Bibliografia: G. Titta Rosa: Vita letteraria del Novecento, V. III.
 '900 Letterario | Letteratura del '900, critica, eventi letterari, cinema, politica, attualità Divulgazione culturale e informazione libera
'900 Letterario | Letteratura del '900, critica, eventi letterari, cinema, politica, attualità Divulgazione culturale e informazione libera