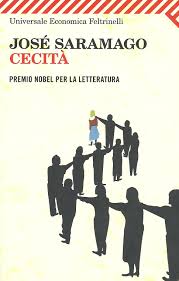Considerato il capolavoro dello scrittore portoghese Josè Saramago, Premio Nobel per la Letteratura nel 1998, Cecità è un racconto-denuncia sulla violenza, la sopraffazione del potere, e la sospensione della ragione dal respiro universale.
In un tempo e un luogo non precisati, l’intera popolazione, improvvisamente, diventa cieca per un’epidemia le cui cause sono oscure. Le persone colpite da questo male si trovano come avvolti in una nube lattiginosa e non ci vedono più. Le reazioni psicologiche dei protagonisti che non vengono mai identificati con i loro nomi, sono devastanti; un’esplosione di terrore, panico e violenza, e gli effetti della patologia sulla convivenza sociale si riveleranno drammatici. I primi colpiti dal male vengono infatti rinchiusi in un ex manicomio per la paura del contagio e l’insensibilità altrui, e proprio in queste pagine Saramago mette in luce in maniera chirurgica tutto l’orrore di cui l’uomo è capace. Nel suo racconto fantastico, lo scrittore portoghese disegna la grande metafora di un’umanità bestiale e feroce, incapace di vedere e discernere; tutto questo porta all’ abrutimento, alla violenza, al degrado umano. Cecità rappresenta il trionfo della bestialità sulla razionalità umana, ma con uno spiraglio di speranza.
“La ragazza con gli occhiali scuri”, “la moglie del medico”, “il primo cieco”, “il vecchio con la benda nera”, Saramago definisce in questo modo i suoi personaggi, quasi a voler dimostrare come la società moderna non tenga in considerazione l’identità delle persone, ridotte a bestie in lotta tra loro per la sopravvivenza, buttati per dirla alla Heidegger, nel mondo e dominati dall’angoscia, sentimento che tiene viva per l’uomo la minaccia della morte. Come fronteggiare tutto questo? Come uscirne? Scegliendo, dando un senso nuovo alla vita, cercando la luce e la salvezza della razionalità rappresentate da una donna ancora vedente. Lo scrittore fa coincidere la cecità degli occhi e della razionalità con quella dell’anima dando scacco matto al potere, che a questo punto non serve più a nulla, vivendo tutti lo stesso incubo.
Tradizione e originalità si mescolano: la prima è data dal ruolo salvifico della donna, una moderna Beatrice e la seconda soprattutto nel linguaggio crudo, duro, destabilizzante (assenza di virgolette nei dialoghi, di punteggiatura, di paragrafi) che conferisce maggiore spietatezza al romanzo, in perfetta linea con la spietatezza del potere e degli uomini. Cecità potrebbe disorientare il lettore con il suo stile “animalesco” che però conduce alla commozione e al coinvolgimento emotivo, ma certamente è un libro da leggere assolutamente; Josè Saramago ci fa odiare noi stessi, è riuscito a rendere osceni, mostruosi e scandalosi quei comportamenti umani, resi anche con una certa fascinazione (“la banalità del male”) a cui purtroppo siamo abituati, davanti ai quali troppo spesso scrolliamo le spalle. Da questo punto vista Cecità è un’opera altamente morale che offre l’occasione per potere riflettere anche su tematiche filosofiche, antropologiche e religiose senza appesantire la narrazione.
 '900 Letterario | Letteratura del '900, critica, eventi letterari, cinema, politica, attualità Divulgazione culturale e informazione libera
'900 Letterario | Letteratura del '900, critica, eventi letterari, cinema, politica, attualità Divulgazione culturale e informazione libera