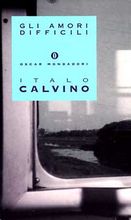“Gli amori difficili” è un libro che fotografa le dinamiche dell’amore da prospettiva diversa: più che sull’amore, sul concetto di “coppia”.
Una relazione è fatta anche di silenzi, momenti sospesi, azioni imponderabili di cui non è possibile prevederne lo sviluppo successivo: Calvino riesce a meraviglia a dare uno spaccato di questa situazione, facendo prendere forma a venti coppie, quaranta persone che nei vari racconti che si susseguono (solo due narrati in prima persona), si guardano, si toccano, si parlano, sognano ad occhi aperti.
L’amore è anche una cosa difficile: paradossalmente Calvino sembra voler dirci che questa particolare relazione tra due persone sia fondata in realtà su un principio di incomunicabilità, su una difficoltà nell’approcciare l’altro, su un disagio verso se stessi che si riflette al momento del contatto con l’altra persona.
Le azioni dei protagonisti de Gli amori difficili sono poche: Calvino ne descrive i piccolissimi particolari, le sensazioni che provano a fare gesti di semplice banalità, dietro a cui si nasconde in realtà l’intera architettura mentale del protagonisti. Azioni semplici, che lasciano spazio al lettore di immaginare e supporre le cause e i motivi di tali comportamenti: come nel caso della storia del fotografo, che smania nel tentativo di prendere la giusta luce per fare la foto. Oppure come nella narrazione del bagnante, in cui semplici gesti (stendere una asciugamano, camminare sugli scogli, guardare il mare) diventano le tende dietro cui si nascondo pensieri e sogni d’amore.
Molte volte i protagonisti rimangono impigliati nelle trame strette dei loro disagi, come accade nell’avventura di un lettore: anche qui gesti semplicissimi nascondono un conflitto interiore che riesce straordinariamente a produrre un effetto sospeso nel lettore.
La seconda parte reca il sottotitolo di “Vita difficile”: l’argomento cambia, la narrazione ora è in prima persona e il protagonista parla al lettore con uno spirito diverso. Il disagio interiore viene trattato non soltanto nel momento del rapporto con l’altro, ma soprattutto come metafora. “La nuvola di smog” vuol dire proprio questo: la nuvola di smog, forse vera protagonista dell’episodio, è la metafora delle nostre paure, della gabbia che ognuno di noi si costruisce e di cui poi non riesce più a disfarsene, perché, in fondo, ci si trova a meraviglia.
Calvino in questo racconto si mette a cavallo tra le sue due anime, quella fantastica, favolistica (per il modo del narrare, molto simile alle “Cosmicomiche”) e quella “neorealista”, per gli argomenti trattati. Calvino cerca sempre di indagare un uomo difficile, controverso, forse simile a quello che lui è nella realtà: lo fa però trovando un compromesso, un punto di incontro tra la sua ingombrante ricerca intima (ma proiettata verso l’esterno) e il tempo in cui vive. In questo modo il disagio dell’uomo moderno è osservato da una prospettiva meno neorealista, meno pedante, ma più colorita e colorata da questo senso di ineffabile che domina tutta la raccolta di episodi di questi amori difficili.
“Solo immergendosi nel cuore della nuvola, respirando l’aria nebbiosa di queste mattine si poteva toccare il fondo della verità e forse liberarsi”.
 '900 Letterario | Letteratura del '900, critica, eventi letterari, cinema, politica, attualità Divulgazione culturale e informazione libera
'900 Letterario | Letteratura del '900, critica, eventi letterari, cinema, politica, attualità Divulgazione culturale e informazione libera