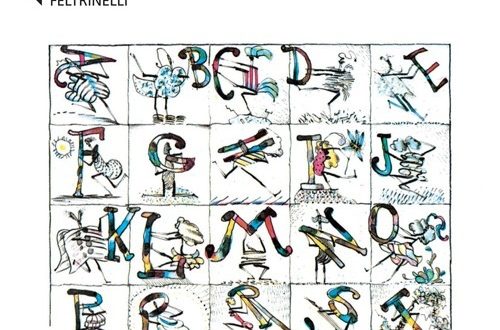Come può l’uomo abbracciare la totalità dell’universo? Come può lo scrittore rendere a parole un concetto così paradossale? Sembrerebbe impossibile, ma se esistesse davvero un punto, un attimo in cui tutti i punti dello spazio e tutti gli attimi del tempo fossero visibili? Il racconto di Jorge Luis Borges, L’Aleph, tratto dall’omonima raccolta, ruota intorno l’incontro tra il protagonista (lo stesso Borges) e Carlos Argentino Daneri, il cugino di Beatriz Viterbo, la sua amata appena scomparsa. Quest’ultimo è un poeta mediocre ma pieno di sé che vorrebbe “mettere in versi tutta la rotondità del pianeta”. Un giorno scopre che deve lasciare la sua casa per fare spazio a una pasticceria. La notizia lo sconvolge: rischia di perdere tutto, Carlos Argentino, rischia di perdere l’Aleph, un punto nascosto in cantina dove si trovano “tutti i luoghi della terra, visti da tutti gli angoli”.
Disperato chiama Borges il quale è certo che quel tipo tanto odiato sia solo un povero pazzo. Lo asseconda e segue le sue istruzioni alla scoperta dell’Aleph: “Ti sdrai sul pavimento di mattonelle e fissi lo sguardo sul diciannovesimo gradino dalla scala. Me ne vado, abbasso la botola e resti solo. Qualche roditore ti farà paura, ci vuol poco! Dopo pochi minuti vedrai l’Aleph. Il microcosmo di alchimisti e cabalisti, il nostro concreto amico del proverbio, il multum in parvo!”
L’incredulità e la meraviglia hanno la meglio quando Carlos Argentino lascia solo Borges…
“Carlos, per difendere il suo delirio, per non sapere che era pazzo, doveva uccidermi . Sentii un confuso malessere, che volli attribuire alla rigidità, e non all’effetto d’un narcotico. Chiusi gli occhi, li riaprii. Allora vidi l’Aleph”. (Nella lingua ebraica l’aleph è la prima lettera dell’alfabeto e rappresenta l’unità divina) Arrivo, ora, all’ineffabile centro del mio racconto; comincia, qui, la mia disperazione di scrittore. Ogni linguaggio è un alfabeto di simboli il cui uso presuppone un passato che gl’interlocutori condividono; come trasmettere agli altri l’infinito Aleph, che la mia timorosa memoria a stento abbraccia? […] Nella parte inferiore della scala, sulla destra, vidi una piccola sfera cangiante, di quasi intollerabile fulgore. Dapprima credetti ruotasse; poi compresi che quel movimento era un’illusione prodotta dai vertiginosi spettacoli che essa racchiudeva. Il diametro dell’Aleph sarà stato di due o tre centimetri, ma lo spazio cosmico vi era contenuto, senza che la vastità ne soffrisse. Ogni cosa (il cristallo dello specchio, ad esempio) era infinite cose, poiché io la vedevo distintamente da tutti i punti dell’universo. Vidi il popoloso mare, vidi l’alba e la sera, vidi le moltitudini d’America, vidi un’argentea ragnatela al centro d’una nera piramide, vidi un labirinto spezzato (era Londra), vidi infiniti occhi vicini che si fissavano in me come in uno specchio, vidi tutti gli specchi del pianeta e nessuno mi rifletté, vidi in un cortile interno di via Soler le stesse mattonelle che trent’anni prima avevo visto nell’andito di una casa di Fray Bentos, vidi grappoli, neve, tabacco, vene di metallo, vapor d’acqua, vidi convessi deserti equatoriali e ciascuno dei loro granelli di sabbia, vidi ad Inverness una donna che non dimenticherò, vidi la violenta chioma, l’altero corpo, vidi un tumore nel petto, vidi un cerchio di terra secca in un sentiero, dove prima era un albero, vidi in una casa di Adrogué un primo esemplare della prima versione di Plinio, quella di Philomen Holland, vidi contemporaneamente ogni lettera di ogni pagina (bambino, solevo meravigliarmi del fatto che le lettere di un volume chiuso non si mescolassero e perdessero durante la notte), vidi insieme il giorno e la notte di quel giorno, vidi un tramonto a Querétaro che sembrava riflettere il colore di una rosa nel Bengala , vidi la ma stanza da letto vuota, vidi in un gabinetto di Alkmaar un globo terracqueo posto tra due specchi che lo moltiplicano senza fine, vidi cavalli dalla criniera al vento, su una spiaggia del mar Caspio all’alba, vidi la delicata ossatura d’una mano, vidi i sopravvissuti a una battaglia in atto di mandare cartoline, vidi in una vetrina di Mirzapur un mazzo di carte spagnolo, vidi le ombre oblique di alcune felci sul pavimento di una serra, vidi tigri, stantuffi, bisonti, mareggiate ed eserciti, vidi tutte le formiche che esistono sulla terra, vidi un astrolabio persiano, vidi un cassetto della scrivania (e la calligrafia mi fece tremare) lettere impudiche, incredibili, precise che Beatriz aveva diretto a Carlos Argentino, vidi un’adorata tomba alla Chacarita, vidi il resto atroce di quanto deliziosamente era stata Beatriz Viterbo, vidi la circolazione del mio oscuro sangue, vidi il meccanismo dell’amore e la modificazione della morte, vidi l’Aleph, da tutti i punti, vidi nell’Aleph la terra e nella terra di nuovo l’Aleph e nell’Aleph la terra, vidi il mio volto e le mie viscere, vidi il tuo volto, e provai vertigini e piansi, poiché i miei occhi avevano visto l’oggetto segreto e supposto, il cui nome usurpano gli uomini, ma che nessun uomo ha contemplato: l’inconcepibile universo”.
Non stupisce di incontrare in questa unica raccolta di racconti un Omero che, per aver bevuto alla fonte dell’immortalità, sembra essere diventato un personaggio di quell’Odissea che continua incessantemente a raccontare; né il soldato tedesco Otto Dietrich zur Linde, che in pieno 1943, si augura la prosperità di altri popoli mentre osserva la catastrofica caduta del suo Reich. Non meraviglia trovare la disputa teologica tra Aureliano e Giovanni di Pannonia (che in realtà scrivono le medesime cose) accanto alla storia di Droctulft, l’invasore longobardo che cambiò parte, accettando di morire al fianco dei ravennati invasi da quella che era stata la sua gente.
Geniale il racconto “La casa di Asterione”, il quale è il mostro che giace dentro ciascuno di noi. Non a caso la struttura narrativa si sviluppa per strade inconsuete (solo alla fine si intuisce che la casa di Asterione è il labirinto del Minotauro) come un gioco di specchi perché l’identità è sfumata: troppo comodo individuare il colpevole. A chi appartiene la colpa? Non certo ad Asterione che, anzi, cerca la propria identità e il fine della propria esistenza. Quale altro è il problema dell’esistenza, dell’identità personale, se non questo? Ognuno è “monstrum” per il fatto stesso d’esser “singolo”, e ogni sforzo per comunicare fra “mostri” è inutile. In questo racconto dell’Aleph, il grido d’angoscia di Borges, (che appare sempre così pacato e quasi distaccato, mentre al contrario è dilaniato incessantemente da questi interrogativi senza risposta) raggiunge l’acme della disperazione. Forse solo con la morte, che riunifica il singolo all’Universo, conosceremo tutto: Asterione “libera” dalla vita le vittime, le sottrae all’orrore dell’eterno vagare nella “casa” (Universo o Labirinto che sia). Lui che ha accettato rassegnatamente la sua inutile parte solitaria ed attende l’avverarsi della profezia che lo libererà (il bronzo di Teseo d’un tratto diventa il “Salvatore” e la profezia si avvera). Funzione catartica, assunta da Asterione, non per una sua scelta, ma quasi ad espiare le nostre colpe: «Ogni nove anni entrano nella casa nove uomini, perché io li liberi da ogni male».
Se ne La scrittura del dio il protagonista si ritrova in un inesauribile labirinto di sogni, che si incastrano l’uno nell’altro all’infinito, allo stesso modo questa lettura de L’Aleph ci confonde con la sua architettura di finzioni, ricorsivi contenitori e contenuti di storie. Un incessante gioco di rimandi, riferimenti circolari e apparenti divagazioni in cui citazioni erudite si mescolano beffardamente a nomi immaginari e situazioni fantastiche, lucidamente raccontate come fatti di cronaca. Le storie sono tante ma in fondo non sono che i molteplici volti di una stessa metafora, che apre le porte a significati difficili da pensare. La scrittura di Borges non è facilmente accessibile ma si fa estremamente colta, erudita, sapiente. Le parole sono ricche e preziose perché diventano esse stesse essenza del raccontare. L’unico modo per pensare l’infinito, il tempo immortale, il destino è, infatti, un infaticabile gioco di specchi da cui lasciarsi sorprendere e confondere. L’Aleph è proprio questo, un insieme di atmosfere rarefatte e personaggi senza volto, di vicende che oltrepassano il confine della realtà, di magie ed evocazioni che attraversano i classici latini, la mitologia greca, la cultura araba. Un vertiginoso labirinto in cui perdersi, per ritrovarsi infine a riflettere pensieri nuovi.
Fonti: http://www.criticaletteraria.org/2012/11/pillole-dautore-l-aleph-jorge-luis.html
 '900 Letterario | Letteratura del '900, critica, eventi letterari, cinema, politica, attualità Divulgazione culturale e informazione libera
'900 Letterario | Letteratura del '900, critica, eventi letterari, cinema, politica, attualità Divulgazione culturale e informazione libera